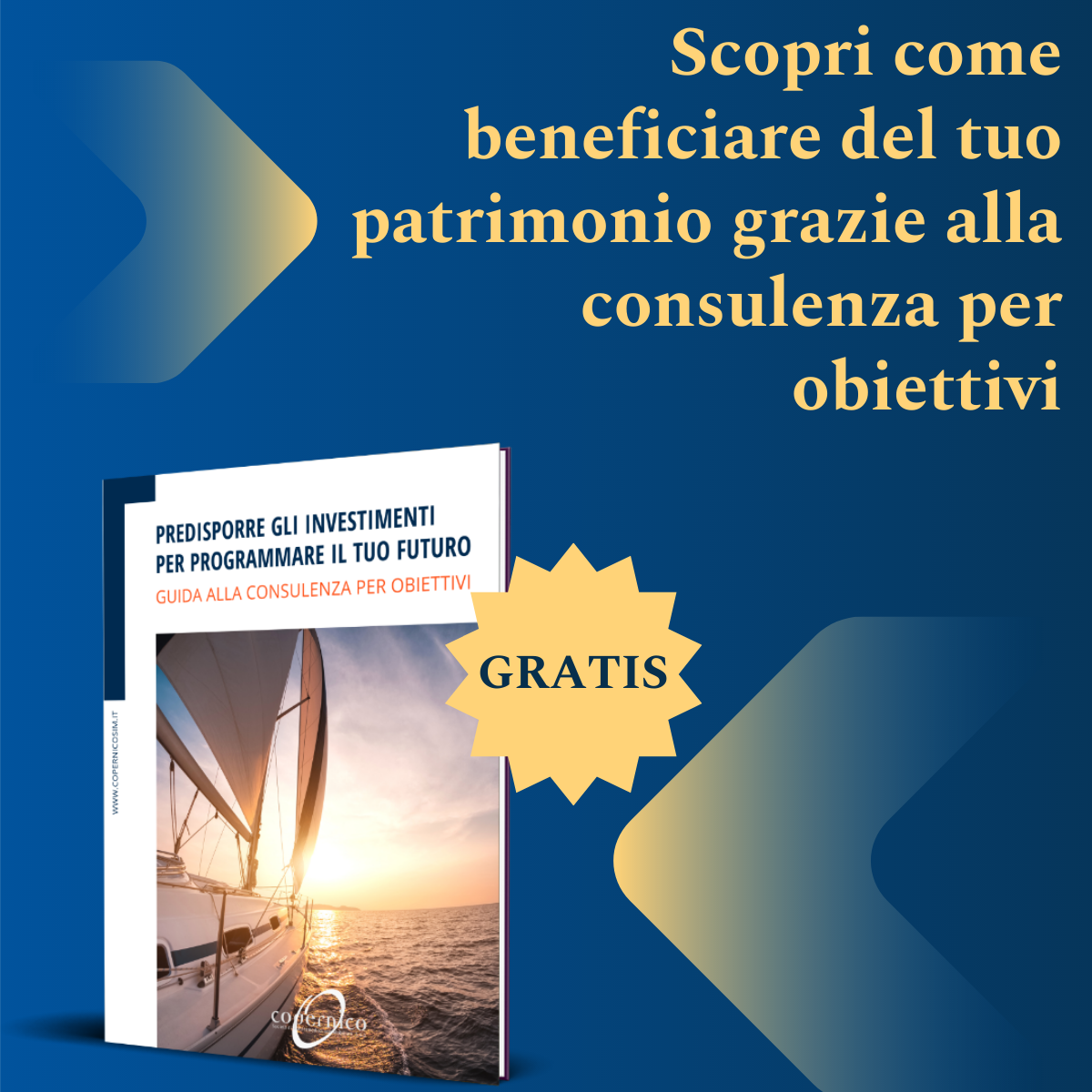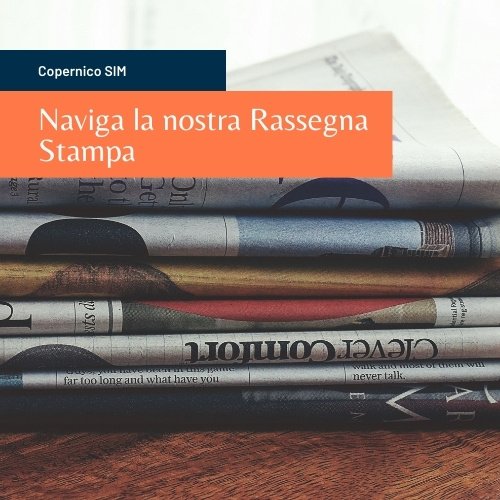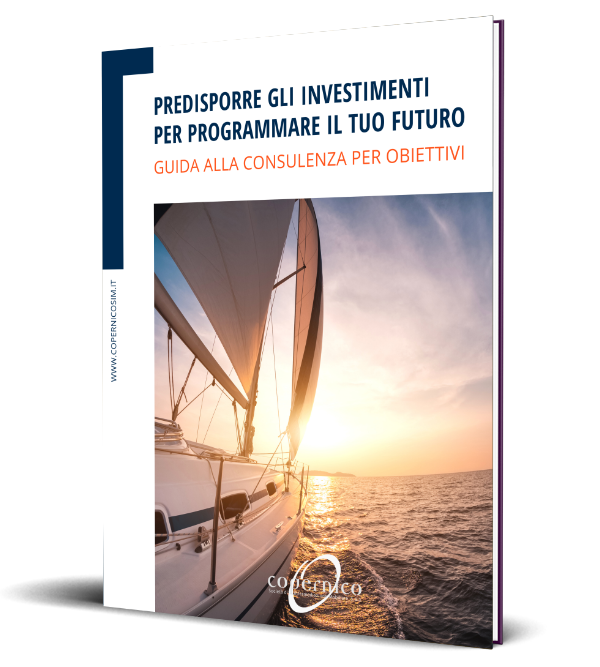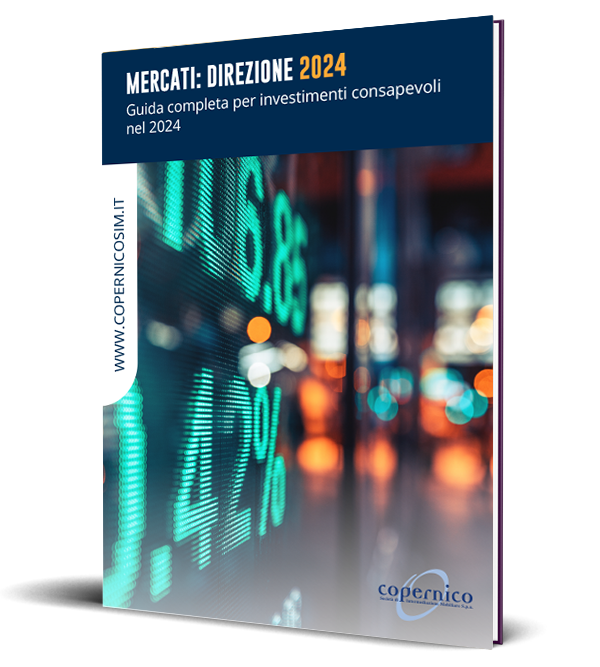Con l’elezione di Sanae Takaichi alla guida del Partito Liberal-Democratico, e di fatto come premier designata, il Giappone entra in una fase politica in cui le scelte di politica economica saranno messe sotto la lente dei mercati globali e degli investitori internazionali.
Takaichi ha già dichiarato che l’obiettivo non è un’inflazione di costo — generata da shock esterni sui prezzi delle materie prime — bensì un’inflazione “trainata dalla domanda”, cioè un processo in cui salari e profitti possano salire insieme e sostenere consumi e investimenti. Nel suo discorso pubblico ha messo in guardia dal rischio che l’inflazione attuale, in parte dovuta alle pressioni sui costi, finisca per compromettere il potere d’acquisto se non accompagnata da aumenti salariali reali. Questa volontà di coordinare le politiche del governo con la banca centrale non è nuova — già precedenti governi giapponesi avevano tentato un dialogo più stretto con la BoJ — ma l’insistenza su una “inflazione da domanda” suggerisce che Takaichi intenda usare la leva fiscale con decisione.
Sul versante monetario, la Banca del Giappone si trova in posizione delicata. Nel suo “Outlook for Economic Activity and Prices” di luglio 2025, la BoJ proietta che l’incremento annuo dell’indice dei prezzi al consumo al netto dei cibi freschi per l’anno fiscale 2025 sarà nella fascia 2,5–3,0 %, per poi scendere nell’orizzonte 2026–2027 verso il 2 %, con un’inflazione sottostante che gradualmente acquisterà forza man mano che la pressione salariale e il ciclo economico si rafforzano.
Tuttavia, questa traiettoria è condizionata alla credibilità delle politiche del governo nel garantire che l’inflazione non sfugga al controllo. Se Takaichi promuoverà pacchetti molto espansivi, i tassi di politica monetaria potrebbero dover reagire più presto del previsto, generando tensioni tra esecutivo e Banca centrale. In parte ciò appare già scontato: un consigliere economico legato a Takaichi ha affermato che un rialzo dei tassi di 25 punti base entro gennaio 2026 sarebbe accettabile — purché la BoJ mantenga un’impostazione complessivamente accomodante.
Sul fronte della spesa pubblica Takaichi sembra pronta a giocare una carta aggressiva. L’esperienza giapponese ha mostrato che investimenti pubblici mirati, trasferimenti condizionati e incentivi agli investimenti produttivi possono avere un moltiplicatore positivo. Ma il punto cruciale sarà come finanziare tali politiche senza rompere la fiducia dei mercati. Il Ministry of Finance ha già delineato nel suo Debt Management Report 2025 una strategia di emissione di titoli governativi con un piano di JGB (Japanese Government Bonds plan) per l’anno fiscale 2025 fissato a circa ¥172,3 trilioni, e una scelta più cauta sui titoli ultra-lunghi, favorendo scadenze intermedie e a breve termine per rispondere alle esigenze del mercato.
Nel rapporto mensile “Japanese Government Bonds 2025”, il Ministero delle Finanze rende noto che al termine di giugno 2025 il debito cumulativo del governo centrale ha raggiunto ¥1.332,2 trilioni, con un incremento di ¥8,5 trilioni rispetto a marzo 2025. La sola componente di debito a lungo termine è salita a ¥1.111,6 trilioni, un nuovo record. Il “Public Finance Fact Sheet FY2025” stima che il debito pubblico totale centrale e locale raggiungerà circa 211 % del PIL al termine dell’anno fiscale 2025.
Questi numeri mostrano che la leva finanziaria del Giappone è già estrema: qualsiasi stimolo ulteriore riduce lo spazio di manovra. Se i mercati cominceranno a dubitare della sostenibilità, i rendimenti dei JGB possono salire, inducendo un effetto “snowball” sul costo del servizio del debito.
La complessità dello scenario economico giapponese aumenta se si considera anche il ruolo del carry trade in yen, una strategia che amplifica le connessioni tra politica fiscale, tassi d’interesse e mercati valutari globali. Il Giappone, da decenni caratterizzato da tassi d’interesse estremamente bassi, ha storicamente rappresentato una fonte di finanziamento a basso costo per gli investitori internazionali. Quando i tassi in Giappone restano inferiori a quelli delle principali economie avanzate — in particolare degli Stati Uniti — gli operatori finanziari tendono a prendere a prestito yen, convertirli in valute ad alto rendimento (come dollari o dollari australiani) e investirli in attività che offrono un ritorno più elevato.
Questa dinamica, nota come yen carry trade, genera un flusso di capitali in uscita dal Giappone e una pressione al ribasso sullo yen, poiché gli investitori vendono yen per acquistare altre valute. Il sistema funziona finché il differenziale dei tassi rimane stabile e la volatilità dei cambi è contenuta.
Tuttavia, se il governo Takaichi dovesse adottare una politica fiscale espansiva, aumentando la spesa pubblica per sostenere la crescita e consolidare l’inflazione, la Banca del Giappone potrebbe essere indotta a mantenere i tassi d’interesse su livelli contenuti più a lungo, per evitare di frenare la ripresa con un irrigidimento prematuro delle condizioni monetarie. In questo scenario, il divario tra i tassi giapponesi e quelli delle principali economie avanzate resterebbe ampio, rendendo nuovamente redditizie le operazioni di carry trade in yen.
Una simile combinazione di politica fiscale espansiva e politica monetaria accomodante riattiverebbe i flussi speculativi in uscita dal Giappone: gli investitori internazionali tornerebbero a prendere a prestito yen a basso costo per investirli in attività denominate in valute a più alto rendimento. Il risultato sarebbe un deprezzamento progressivo dello yen, con effetti ambivalenti sull’economia domestica. Da un lato, una valuta più debole favorirebbe le esportazioni, migliorando la competitività dei prodotti giapponesi sui mercati globali; dall’altro, aumenterebbe il costo delle importazioni di energia e materie prime, alimentando inflazione importata e riducendo il potere d’acquisto delle famiglie.
Se invece la Banca del Giappone decidesse di reagire in senso opposto, accelerando il ritmo dei rialzi dei tassi per contenere l’inflazione o difendere la valuta, l’effetto immediato sarebbe quello di ridurre la redditività del carry trade in yen. Tuttavia, un cambio di rotta improvviso potrebbe innescare un fenomeno opposto e potenzialmente destabilizzante: di fronte all’aspettativa di tassi più alti o a un rafforzamento repentino dello yen, gli investitori tenderebbero a chiudere simultaneamente le loro posizioni, vendendo asset rischiosi e ricomprando yen per rimborsare i finanziamenti. È il cosiddetto rischio di unwind, ossia la chiusura collettiva e disordinata delle posizioni di carry trade, che può generare forti movimenti dei prezzi, perdita di liquidità e un aumento improvviso della volatilità sui mercati valutari e obbligazionari.
Un’ondata di unwind di ampia portata avrebbe effetti a catena: un rafforzamento improvviso dello yen, una correzione dei mercati azionari e obbligazionari nei Paesi in cui erano stati investiti i capitali presi in prestito, e un incremento generalizzato dell’avversione al rischio. Si tratta di un pericolo concreto, documentato in più occasioni.
In definitiva, il successo politico ed economico di Sanae Takaichi dipenderà dalla credibilità che riuscirà a costruire nei primi mesi di governo. Se saprà mantenere ancorate le aspettative di inflazione e rassicurare i mercati sulla sostenibilità del debito, il Giappone potrà avviare una fase di crescita più equilibrata, sostenuta da investimenti e salari reali in aumento. Ma se, al contrario, saranno il debito e il carry trade a dettare l’agenda, il Paese rischierà di entrare in una nuova stagione di volatilità sistemica, segnata da oscillazioni dello yen, tensioni sui rendimenti dei titoli di Stato e un ritorno a quell’instabilità macroeconomica che Tokyo sperava di aver definitivamente superato.